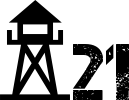Il deserto intorno ai confini del Texas è il luogo in cui criminali e indesiderati vengono esiliati nell’America creata da Ana Lily Amirpour per il suo thriller distopico uscito nel 2016, The Bad Batch.
Un misto tra un film di Carpenter e Mad Max, il film datato 2016 (e disponibile su Netflix) vede la presenza di un cast incredibile e sfrutta una colonna sonora d’eccezione per valorizzare la sua fotografia patinata che va in contrasto con i temi e le scene rappresentate in un’opera tanto cruda da tenere lo spettatore in bilico, in un equilibrio solo apparente, come quello vissuto dai protagonisti.
Suki Waterhouse, Jason Momoa, Giovanni Ribisi, Keanu Reeves e uno straordinario Jim Carrey in un prodotto scritto e diretto dalla regista di origini iraniane che, sebbene forse un po’ lento nel suo svolgimento, è estremamente efficace nel lanciare il suo messaggio rimarcandolo così tanto da farlo sembrare ovvio e scontato, salvo poi colpire in maniera ancora più atroce.

Il viaggio di Arlen nel deserto-prigione
The Bad Batch comincia con l’esilio di Arlen nel deserto prigione che costeggia il Texas, là dove il governo degli USA non ha legislazione e non protegge da niente e da nessuno. La ragazza lo impara in fretta, venendo catturata da un gruppo di cannibali che le amputa il braccio e la gamba destri prima che riesca a liberarsi e a fuggire nella vastità dell’arido carcere.
Quando Arlen verrà salvata da un misterioso eremita, entrerà a far parte della comunità di Comfort, dove la vita sembra decisamente più accettabile che nell’area desolata intorno alla cittadina.
Il desiderio di vendetta e tutto quello che le accadrà successivamente le faranno capire che non sempre quello che luccica è davvero oro, e segneranno per sempre il suo modo di vivere l’esilio.

The Bad Batch luccica per mostrare il buio
The Bad Batch comincia con il piede sull’acceleratore con la scena dell’amputazione e la presentazione degli abitanti del Ponte, per poi abbassare il ritmo tenendo lo spettatore quasi sospeso in una sorta di limbo che somiglia a quello dei protagonisti, intrappolati e in attesa di qualcosa di indefinito.
Uno dei punti forti dell’opera della Amirpour sono proprio i personaggi, mai troppo raccontati e di cui non ci resta altro che l’aspetto fisico e i comportamenti, a volte improbabili o dall’apparente poco senso, ma che ne raccontano la personalità e ne esplicitano l’attitudine in cattività e non solo.
Perché quello della prigione non è altro che un espediente per raccontare il nostro mondo e le nostre società in un altro modo, da un punto di vista più distaccato: Comfort e il Ponte non sono tanto le rappresentazioni di quello che siamo, quanto piuttosto di dove siamo cresciuti, e di come siamo stati abituati a vivere, per necessità e, a volte, ovviamente, anche per scelta.
La questione diviene più chiara in un dialogo tra il Miami Man (personaggio dai tratti all’apparenza estremamente contraddittori) di Jason Momoa e Arlen, quando il cannibale, senza specificare se stia parlando della sua origine cubana o della sua appartenenza alla comunità del Ponte fa capire alla ragazza come lei non possa comprendere uno stile di vita che non conosce e di cui non può intuire le motivazioni o gli ideali.
Il personaggio del Sogno (interpretato da Keanu Reeves), allo stesso modo, non può che rappresentare l’antitesi di Miami Man e una società imperniata su altro e che si regge sulla comodità, sull’intrattenimento e sul servizio per nascondere tutte le sue contraddizioni e i reali interessi di chi la porta avanti.
È una sorta di contrapposizione tra chi vive la legge della strada e chi si nasconde dietro una società costituita da leggi. E quello che ne esce fuori è che la differenza non è poi così tanta, a pensarci bene.
In tutto questo si inseriscono poi due personaggi completamente al di fuori di ogni logica: il folle Urlatore interpretato da Giovanni Ribisi e l’Eremita di Jim Carrey, che sembrano vivere in quei due mondi senza appartenervi realmente.
Una menzione d’onore, in questo senso, la merita proprio l’interpretazione di Carrey, quasi irriconoscibile nel trucco e che senza mai proferire parola dona al suo personaggio un carisma e un’importanza straordinaria nonostante i pochi minuti in scena.
L’opera della Amirpour alterna momenti di lenta austerità ad altri di frenesia e confusione, con una regia che sa bene adattarsi alle situazioni e che sembra sapere sempre cogliere il punto focale delle situazioni messe in scena.
La fotografia patinata, che a una prima impressione sembra stonare con tutto il resto, è in realtà perfetta per regalare a chi guarda un’altra dissonanza cognitiva, come se lo sporco potesse essere impacchettato, infiocchettato e venduto o come se The Bad Batch non fosse nient’altro che quello: corpi, stile e tecnica, lucidati e messi in bella mostra.
Menzione d’onore per la colonna sonora, tanto azzeccata che in alcuni momenti il film si trasforma quasi in un video musicale e capace di trasportare, insieme a dei girati quasi onirici, in una dimensione parallela rispetto a quella raccontata nel film.


The Bad Batch è un film moderno e scrupoloso
The Bad Batch, dunque, è un film dalla fortissima personalità, che non teme di mettere in mostra la forma e finge di voler nascondere la sostanza, con cui in realtà colpisce lo spettatore senza pietà fino alla scena finale, che è il culmine del tutto e che lascia di sasso, nella sua semplicità.
Un film che ha diviso e dividerà, che può piacere o lasciare totalmente indifferenti e anzi, infastiditi dal suo ritmo altalenante.
Noi siamo rimasti ammaliati dal suo racconto e stupiti dalla sua profondità, ma, forse, apparteniamo, o quantomeno ci piace sentirci vicini, a quel lotto difettoso di cui parla il titolo.
Voto The Bad Batch: 7.5/10