Cassandra è una miniserie tedesca distribuita da Netflix in sei episodi e chiamata a raccontare l’incontro tra una famiglia e l’assistente domestica ipertecnologica costruita e installata dal pretendente proprietario negli anni ’70 del ventesimo secolo.
Nonostante l’importante richiesta di sospensione dell’incredulità per alcune situazioni riportate, lo show affronta problematiche etiche e sociali che sembrano diventare sempre più concrete mentre la nostra società continua a evolvere e mano a mano che i progressi scientifici avvicinano la nostra umanità a nuovi obiettivi, ritenuti fino a poco tempo fa improbabili, e, in qualche modo, a un nuovo stadio evolutivo.
Dopo aver condiviso la nostra spiegazione del thriller Blink Twice, diretto da Zoë Kravitz e avvisando degli spoiler presenti nelle righe che seguono, andiamo dunque ad analizzare i punti salienti della narrazione ideata e diretta da Benjamin Gutsche.

La trama di Cassandra
Trasferitisi in una nuova casa a seguito di una tragedia familiare, David, Samira e i loro due figli, scoprono che il sistema di smart home progettato decenni prima è ancora funzionante nonostante gli anni passati e lo stato d’abbandono.
Cassandra, il robot che controlla ogni meccanismo della casa, però, non è guidata da una semplice intelligenza artificiale, essendo in realtà frutto di un esperimento transumanista d’avanguardia attraverso il quale Horst Schmitt aveva cercato di mantenere in vita la moglie vittima di un cancro incurabile.
L’essere metà donna e metà macchina si rivelerà estremamente possessiva nei confronti dei due ragazzi della famiglia e allo stesso modo ostile contro la madre, iniziando una guerra che non tarderà a passare dal piano psicologico a quello più terribilmente concreto.

Il tema del diverso e del mostro
Uno dei temi portanti della miniserie è rappresentato dalla percezione e dall’emarginazione del diverso, trattato, nelle sue diverse declinazioni, quasi come un mostro da curare o da escludere dalla società.
È quanto succede in primis al figlio di Cassandra e Horst, Peter, considerato dal padre troppo poco virile visti i suoi interessi lontani dal sentire comune, e quindi alla secondogenita della coppia, nata con diverse malformazioni e per questo mai accettata da Horst, estremamente preoccupato dai pettegolezzi e da una presunta crudeltà del mondo esterno che probabilmente risiede soprattutto nella sua testa.
Se lo stesso trattamento viene riservato da David alla sorella di Samira a causa dei suoi problemi mentali, il complesso processo che porta a un cambio di paradigma è più chiaro per quanto riguardi l’orientamento sessuale di Fynn, compreso senza remore dai due genitori al contrario di quanto avvenga per Steve, suo interesse amoroso rinchiuso in una logica di comunità più ristretta ed evidentemente meno aperta di fronte a quello che in qualche modo viene percepito come non consueto.
A estremizzare il concetto c’è la figura di Cassandra, macchina dall’intelletto e dallo spirito umano, intrappolata in un limbo incomprensibile per tutti gli altri che non riescono a riconoscere in lei un essere umano con tutte le fragilità e le contraddizioni del caso.

Le implicazioni etiche che riguardano un nostro possibile futuro
Il ruolo di Cassandra ci conduce anche verso l’altro argomento principale del racconto, costituito dalle implicazioni etiche e dalle difficoltà di gestione di un processo che, per quanto ancora appartenente soltanto al regno della fantascienza, si è fatto, soprattutto negli ultimi anni, almeno parzialmente più vicino al lavoro fatto dai ricercatori del campo.
L’idea di poter trasferire la mente su un supporto artificiale affascina da tempo gli autori e gli appassionati di mondi futuristici e, soltanto più di recente e in maniera certamente circoscritta a un ambito di studio teorico e pratico, i ricercatori che si occupano di longevità e di potenziamento dell’essere umano, divenendo un concetto chiave delle infinite possibilità del fenomeno del transumanesimo.
Al di là dei limiti tecnologici che ancora ci separano dalla concreta possibilità di mettere in atto una rivoluzione di questo tipo, i conflitti interiori ed esterni affrontati da Cassandra anticipano i rischi etici e sociologici di un processo incredibilmente ammaliante e allo stesso tempo mostruosamente alienante per quanto riguardi l’idea stessa di essere umano.
Tanto la famiglia protagonista della serie quanto i familiari di Cassandra faticano infatti a riconoscere in lei l’umanità che alberga tra le lamiere robotiche del suo corpo, sentendola lontana e minacciosa ogni qualvolta lei esprima sensazioni ed emozioni che non siamo soliti riconoscere in una macchina.
Di pari passo cresce l’alienazione della cyborg, che vorrebbe continuare a comportarsi da essere umano ma che, per barriere strutturali e per diffidenza, è costretta a limitarsi a pensare come donna e a essere trattata come macchina.
Per estensione si potrebbe immaginare una situazione simile nei confronti di quelle intelligenze artificiali che, una volta sviluppatesi in maniera molto più complessa di quanto vediamo oggi, potrebbero cominciare a percepirsi in modo diverso rispetto a un semplice strumento per l’uomo.

Il finale di Cassandra
Nel finale della serie tv, Cassandra, in seguito a una conversazione con Samira, decide di lasciarla andare comprendendo il suo affetto per i figli una volta ricevuta lo stesso tipo di vicinanza da parte della donna.
La risoluzione del dramma raccontato nei sei episodi avviene nella realizzazione di come Cassandra abbia deciso di essere trasformata in un robot per continuare a essere di sostegno ai propri figli, in particolare alla seconda, più bisognosa di protezione e alla comprensione di come quella necessità appartenga anche a Samira, soprattutto a causa delle incongruenze nel comportamento egoista di David.
La scena finale è in questo senso un inno al potere dell’affetto incondizionato e alla sua capacità di ispirare e di rimanere concretamente importante e risolutore anche soltanto nella sua concezione e nella sua idealizzazione.
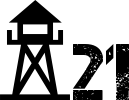
Pingback: San Valentino: 5 film da regalarsi - Torre 21